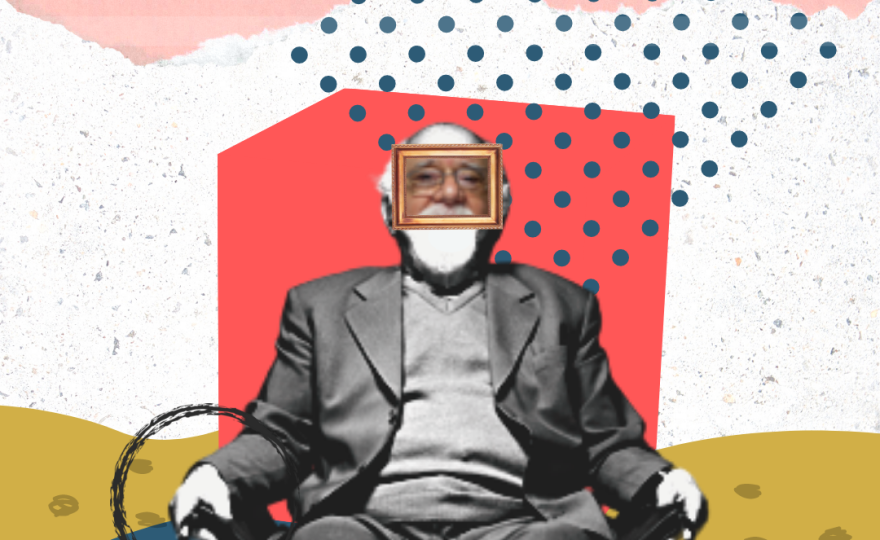Le lancette del mio vecchio orologio sobbalzano mentre marcio verso il ristorante dove i Soares aspettano da più di un’ora. Dietro di me c’è Alba, a chiudere la carovana Massimo che zoppica.
Quando ci impantaniamo in un ritardo africano dipende da un motivo e nel nostro caso ha un nome, e di certo anche un cognome che però non ho avuto la prontezza di chiedere.
A ogni proposta di visitare la nostra amata Lisbona, Alba ci guarda come se la invitassimo a scalare l’Himalaya a piedi nudi. Ma quando ha saputo che c’è stata Greta, l’amica “figa”, ha deciso di accontentarci. Peccato che si alzi quando le portiamo il pranzo, esca all’imbrunire per via dell’afa e sbuffi davanti a ogni salita superiore all’un per cento di pendenza.
Per questo ho pensato al Tuk-tuk.
«Non è troppo da turisti?» ha detto Massimo.
Devono essergli venute in mente le nostre camminate giovanili su e giù per la Mouraria: le gambe indolenzite, il fiato mozzato, fare l’amore in barba all’acido lattico.
Ho insistito per la bimba. Ha tredici anni la bimba.
Con la promessa di tornare in tempo per il terzo shampoo della giornata, otteniamo da lei il nulla osta a prenotare un giro con Lisbon tuk-tuk.
L’asfalto di piazza Marquês de Pompal ribolle sotto i sandali, perciò saltiamo volentieri sullo strombazzante Tuk-tuk che arriva avvolto in un polverone grigio.
Al volante c’è un tipetto con il volto invaso da una barba riccia e brizzolata, il cappello sugli occhi, le lenti a specchio.
«We go to elevador da Bica?» chiede. Sorride.
Tra i denti ha qualcosa di giallognolo.
Massimo risponde di sì e si mette in mezzo, perché Alba vuole stare di lato per i selfie, ma il veicolo si abbassa sotto il suo peso: è un po’ ingrassato dai tempi della Mouraria.
«Come si chiama? È di qui?» chiedo.
«Soy Diogo. Of course» risponde.
La mescolanza linguistica però non mi convince.
Diogo ci tiene a mostrare ogni singola pietra del percorso, tanto che impieghiamo quaranta minuti ad arrivare. L’unica a gradire il passo processionale è Alba, forse perché assicura sfondi non troppo mossi.
Finalmente Diogo si ferma e si schiarisce la voce: «Elevador muito antigo and…»
«Grazie, ma non abbiamo tempo. Possiamo continuare?» lo interrompo.
Abbassa le lenti. Ha gli occhi verde oliva, quasi gialli. Come la roba tra i denti.
Fatico a sostenere il suo sguardo. Mi viene il dubbio che provenga da qualche stato del Sudamerica dove le offese si lavano col sangue.
«Como quiser».
Riavvia il Tuk-tuk e dà un’accelerata.
Ora so che, in punto di morte, è proprio vero che tutta la vita ti scorre davanti.
Nel quarto d’ora successivo Diogo affronta curve, salite e discese sollevando almeno una delle ruote posteriori. Rivedo la mia infanzia, il giorno della laurea, Massimo assunto alla ASL, la nascita di Alba quando andavo per i quaranta, la mia cattedra invasa dalle carte. Ogni tanto il film si interrompe ma non c’è la pubblicità, bensì il selciato a onde di Praça Rossio a un centimetro dal mio viso, Massimo con una mano sulla bocca, o Alba che grida che le foto così escono male. In sottofondo colgo descrizioni frammentarie «arco rua Augusta… muito antigo…» finché, a Nossa Senhora do Monte, il veicolo inchioda e per poco non ci sbalza in avanti.
«Photos!» fa Diogo e indica il belvedere.
Sto accarezzando l’idea di scappare, quando Massimo mi tende la mano per scendere.
Subito Alba inizia a dirigerci come una troupe, ma appena Diogo ci richiama con un fischio io e lei saltiamo su prontamente, mentre Massimo è costretto a inseguirci.
Salendo guaisce e si tocca la caviglia.
Diogo guida in maniera impeccabile fino al Museo del fado dove si ferma per offrirci un bicchiere di ginjihna.
Davanti allo sbadiglio spudorato e al gesto di rifiuto di Alba, mugugna qualcosa, ci guarda di traverso e domanda che lavoro facciamo.
«Io sono insegnante e lui pedagogista» dico.
I suoi baffi sono folti, ma capiamo lo stesso che se la ride lì sotto.
Ripartiamo in silenzio.
Dico ad Alba di mettere via lo smartphone, ma è troppo tardi.
Incrocio il mio sguardo allo specchietto e noto le rughe infittite intorno agli occhi: anche io mi sento “muito antiga”.
Quando intravediamo la statua del Marquês de Pombal, Diogo prende a raccontare del terremoto di Lisbona del 1755, dello tsunami e di altre disgrazie correlate. Alba lo segue con uno strano trasporto, facendo qualche domanda e scordandosi delle foto e dello smartphone. Al capolinea gli lasciamo la mancia, certi che altrimenti tirerà fuori l’animo vendicativo da soap opera latina, lui ci saluta togliendosi il cappello e solo allora vedo che è calvo. Mentre ci incamminiamo verso l’albergo mia figlia leva un grido.
«Lo smartphone!» Si siede a terra e svuota la borsa.
Diogo è troppo lontano, ma la forza della disperazione spinge Alba a emettere un fischio sonoro che lo richiama indietro. Ispezioniamo invano il Tuk-tuk e a quel punto non abbiamo scelta: dobbiamo rifare il tragitto. Domanda: quando tempo impiegheremo perlustrando tutti i bordi delle strade di Lisbona, i cestini della spazzatura, gli angoli delle piazze, chiedendo a negozianti, autisti, ambulanti se si sono imbattuti in un iPhone rosa? Risposta: quasi tre ore.
Sono le nove e un quarto quando torniamo al punto di partenza a mani vuote. Diogo è dispiaciuto, Massimo allunga altri centocinquanta euro per quello che si è rivelato il tour di Lisbona più costoso della storia, e Alba si scusa di sua volontà (miracolo).
Non possiamo dirigerci con lenta mestizia al ristorante solo per via del ritardo.
A tavola Massimo mostra la caviglia: stesso diametro di quella di un elefante.
Torno a guardare l’orologio e vedo che le lancette sono ferme: un chiaro segno del destino.
L’assenza dell’iPhone rende più semplice la comunicazione di Alba con i Soares (che hanno affrontato l’attesa con un lungo aperitivo) e il figlio Nuno, un ruvido diciassettenne più interessato al calcio che agli smartphone.
Ordiniamo dolce e Porto quando si presenta un uomo.
Finché Alba non si avventa su di lui non riconosco Diogo, senza occhiali e col testone glabro in bella vista: in mano ha il telefono, trovato in una cavità sotto il sedile. Da come parla con i Soares capisco che è davvero di Lisbona e che ha creato il suo grammelot a forza di scarrozzare gente di tutto il mondo.
Si congeda senza accettare la mancia e Massimo sospira sollevato.
Beviamo in silenzio, Alba controlla i messaggi e Nuno la guarda sprezzante. Continuo a pensare che il colpevole di tutto abbia un nome. Ma non è Diogo.
Per questo strappo lo smartphone dalle mani di Alba.
«Sei sopravvissuta quattro ore, resisti fino a domani!» dice Massimo mentre lei protesta.
I Soares la fissano.
Alba mette il broncio, ma dopo un minuto di silenzio vede passare un vassoio con dei bicchieri di ginjinha e chiede: «Posso?»
Io e Massimo ci guardiamo.
Di certo pensiamo la stessa cosa: in fondo c’è ancora speranza.
Ti è piaciuto questo racconto? Leggi anche quelli delle altre fermate!