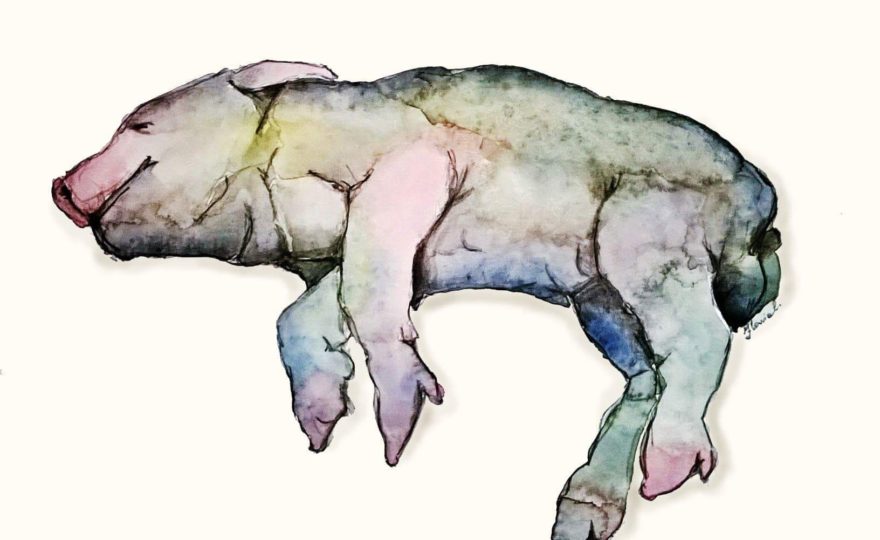di Mariangela Romanisio
illustrazione di Anastasia Coppola
Sono il sessantatré, faccio sempre lo stesso percorso, guidato dal solito autista che non mi strapazza troppo e mi dà quello che mi serve per andare avanti. Però mi annoierei, se non fosse per la varia umanità che mi usa e mi calpesta quotidianamente, o mi verga i sedili con scritte ironiche, tipo: “Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?…” o con altre non dirette a me.
Sì, sono guidato, ma il lavoro più pesante lo svolgo io, a piano carico.
Non sono mai stato un autobus con la spocchia, io ricevo tutti quelli che vogliono salire, agevolando (sono predisposto) anche gli invalidi e i portatori di handicap, ma certi personaggi mi stanno sulle sospensioni più di altri.
Come quel giovinastro, oggi, che mi guardava in lungo e in largo col labbro schifato e il naso arricciato, di certo pensando di stare su un mezzo inadeguato a trasportare la sua persona. Mentre era lui ad umiliare me, un autobus militante dalla gran carriera, dal motore rodato, che ha trasportato centinaia, ma che dico centinaia, migliaia di persone in salvo da un capo all’altra della città, e spesso a sbafo. Non sono io a puzzare di mio, è gente come lui che mi fa puzzare!
Lui, col suo collo da giraffa bonsai, un cappello con un residuo filamentoso di nastro argentato da uovo di Pasqua, l’aria da borioso tracotante, il tipo di passeggero che non si fa da parte quando chiunque altro si accorgerebbe di dover lasciare un corridoio sulla piattaforma per l’altrui discesa.
Lui, il tipo di passeggero che si fionda sull’unico posto libero, senza fare circolare lo sguardo in cerca di un anziano, una donna incinta, cui il sedile spetterebbe per consuetudine civile.
Sono stato contento per lo strattone datogli da quell’altro nell’occasione di una fermata affollata, proprio mentre l’autista (che combinazione efficace) mi frenava di colpo, così all’arrogante gli si è staccato anche un bottone del soprabito. Ben gli stava!
Come il mio gas di scappamento addosso, quando è sceso, mentre mi girava dietro per attraversare la strada.
Mi piace percorrere il Viale dei tigli, con le fronde che mi accarezzano le fiancate, è una gradevole sensazione.
Lì l’ho rivisto, stasera, nei pressi di un bar, quel collo da giraffa bonsai col gozzo in evidenza, mentre stava con un altro che lo fissava con uno sguardo obliquo, lui e il suo soprabito stazzonato e strattonato, blaterando di sicuro per recriminazioni del suo quotidiano rapportarsi al prossimo.
È capitato a proposito centrare in velocità con una gomma la pozzanghera che gli ha schizzato una scarpa: quello ha emesso un verso sguaiato e mi ha gridato dietro, anche se non mi ha riconosciuto.
So di essere meglio di lui: c’è più vento di boria in lui che aria nelle mie gomme, di sicuro, che non sono a terra.
Io sono un mezzo di trasporto al servizio altrui, lui è un mezzo uomo che serve solo al trasporto della sua vana tracotanza fra l’altrui deprecazione.